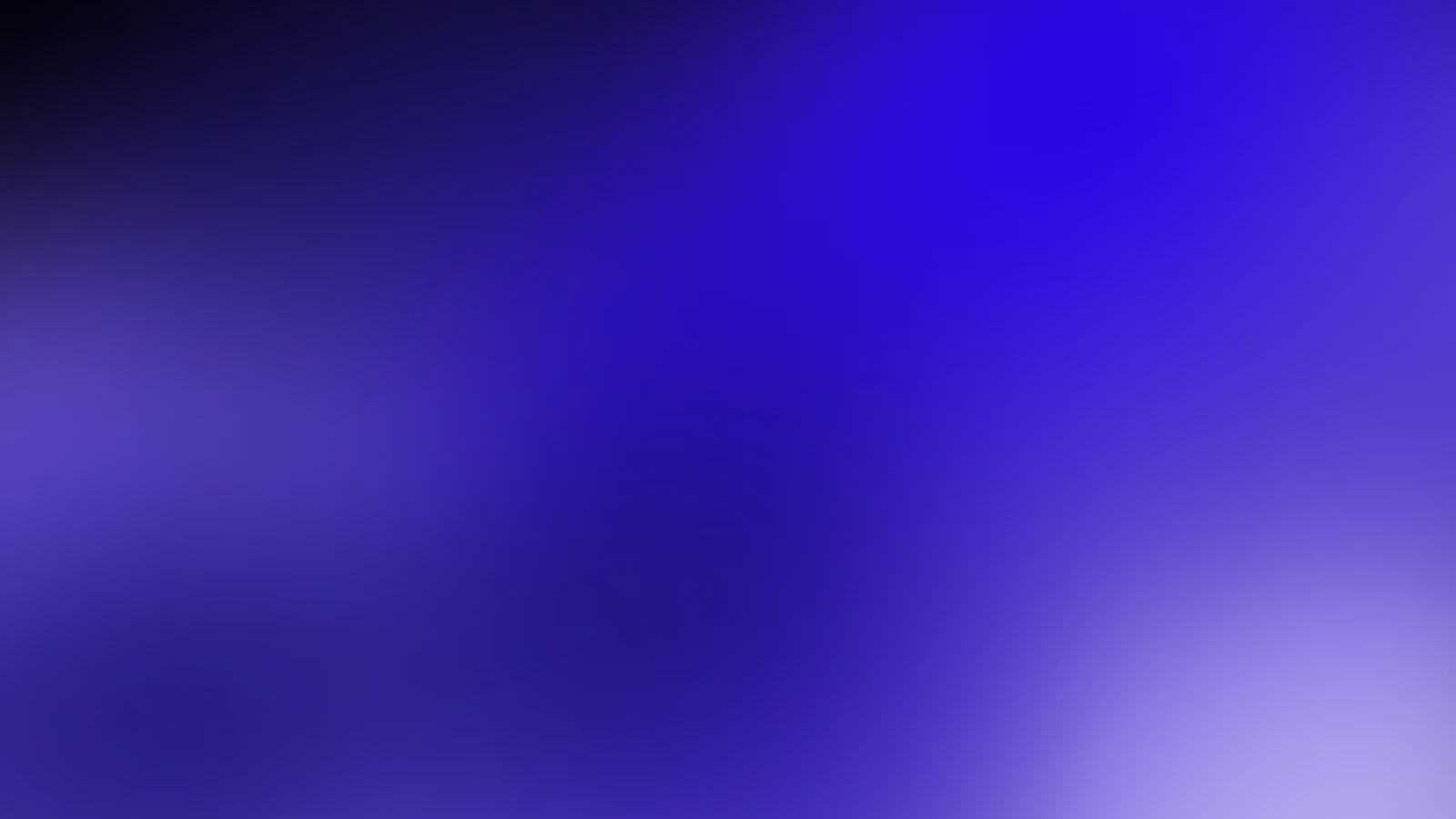
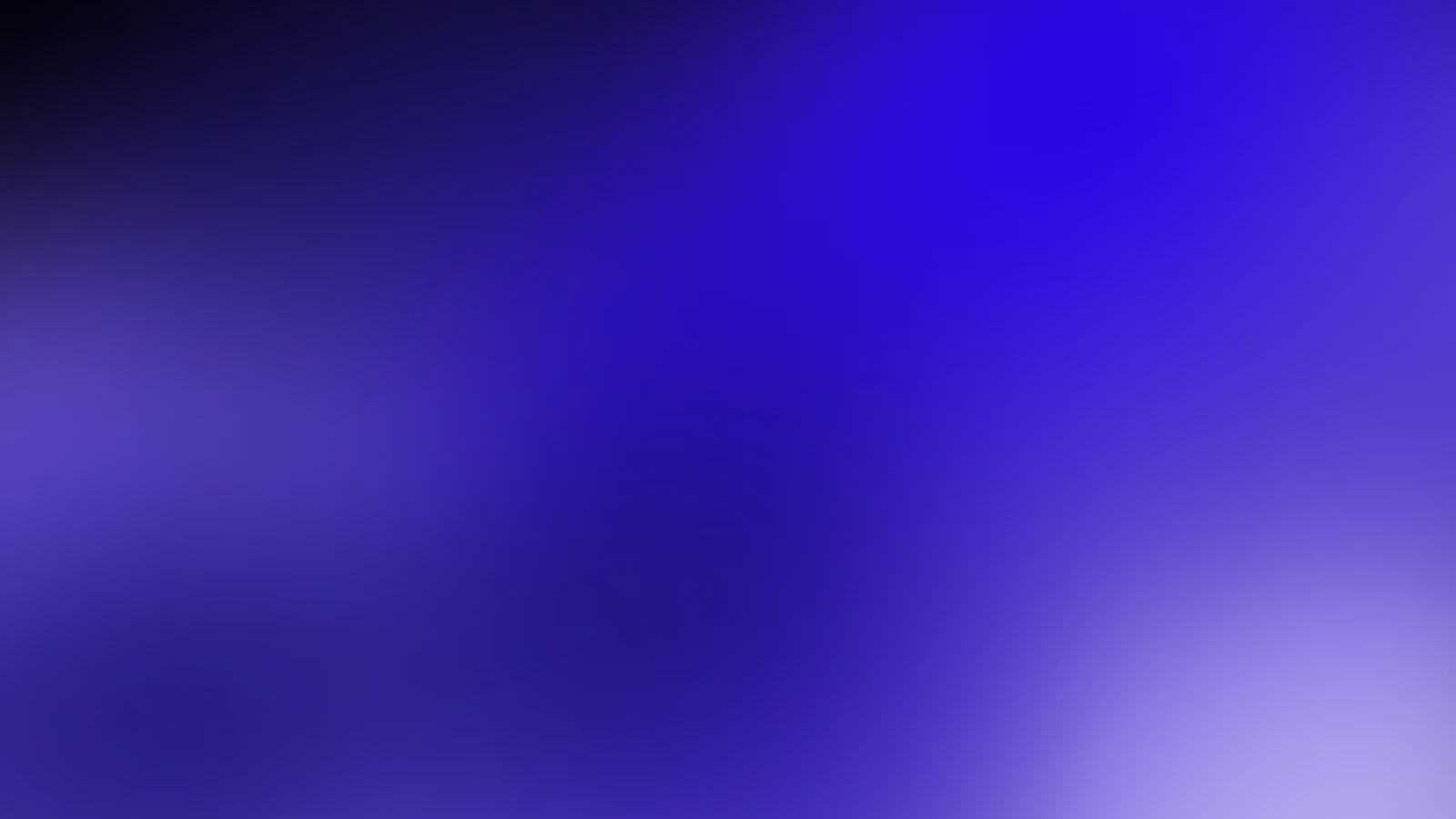

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Negli ultimi dodici mesi i fari si sono spostati: l’AI corre e chiede potenza elettrica. Non è solo un tema di modelli sempre più grandi o di nuovi use case: è una questione fisica, di energia e infrastrutture. Secondo l’IEA — la International Energy Agency, che monitora i consumi globali di elettricità e le dinamiche dei sistemi energetici — i consumi dei data center potrebbero raddoppiare entro il 2030, raggiungendo circa 900–950 TWh/anno, grosso modo quanto consuma oggi il Giappone (fonte: IEA, Electricity 2024 – Data Centres and Digital Technologies).
È una crescita trainata soprattutto dall’AI generativa, che non è solo un fenomeno digitale, ma un nuovo carico fisico sui sistemi elettrici globali. Tradotto: se nel 2024 i data center hanno consumato circa 415 TWh, in pochi anni ne servirà oltre il doppio.
Qui il punto diventa inevitabile: l’AI non può e non deve scalare ai danni del pianeta. Per reggere questa curva senza bloccare l’innovazione né rallentare la transizione, deve scalare anche il Cleantech. E perché il Cleantech possa scalare davvero, non basta avere tecnologie promettenti: servono ecosistemi fertili, territori in grado di trasformare soluzioni in capacità industriale, di integrare nuova domanda elettrica, accumuli, reti, processi produttivi.
Il prossimo salto, quindi, non sarà tecnologico, ma territoriale: dove le soluzioni diventano industria, lì nasce il vero impatto.
In questo contesto, il riposizionamento delle agende industriali diventa più leggibile. Negli ultimi dodici mesi la Difesa è tornata prioritaria nei bilanci, molte strategie hanno riallineato tempi e capitali, e il Green Deal è apparso a tratti “in secondo piano”. Leggere questo cambio come un downgrade della transizione è però fuorviante. In un mercato che sta entrando in fase di maturità — come mostra il State of Climate Tech Q3 2025 — il Cleantech smette di essere un capitolo a parte e diventa l’infrastruttura abilitante della nuova economia, anche e soprattutto per sostenere in modo sostenibile la curva dell’AI.
Il report fotografa un mercato diverso da quello del triennio 2020–2022: nel Q3 2025 le startup climate tech hanno raccolto 11,1 miliardi di dollari di equity, contro gli 11,5 miliardi del Q2 e i 10,2 del Q1, ma con meno deal e ticket medi più grandi. Gli investitori hanno alzato l’asticella: meno operazioni, più qualità. L’equity resta la spina dorsale del settore, mentre il funding non diluitivo rallenta soprattutto negli USA.
Un chiarimento geografico: perché gli USA attirano più capitale e perché è rilevante ciò che accade altrove.
Il prossimo salto non sarà tecnologico, ma territoriale: dove le soluzioni diventano industria, lì nasce il vero impatto.
Gli Stati Uniti assorbono oltre il 65% dell’equity globale nel climate tech. Non perché siano gli unici leader, ma perché il capitale più propenso al rischio industriale converge dove infrastrutture, policy e domanda sono più mature.
Ma il dato davvero interessante — e spesso sottovalutato — è un altro: il report State of Climate Tech evidenzia che i grandi round avanzati non sono più confinati ai soli hub tradizionali. Non si concentrano soltanto in Silicon Valley, Londra o Tel Aviv. Iniziano ad emergere in territori che, fino a poco fa, non erano percepiti come “centri dell’innovazione”, ma che hanno una qualità decisiva: la capacità di attivare ecosistemi coerenti, grazie all’allineamento fra risorse locali, filiere esistenti e domanda reale.
Alcuni casi recenti lo dimostrano in maniera esemplare:
Messico, dove la convergenza tra logistica, automotive e domanda urbana ha accelerato modelli di mobilità elettrica scalabile. Il caso più emblematico è VEMO, che nel 2025 ha ricevuto un commitment di 250 milioni di dollari da Vision Ridge Partners, dopo un round da 63 milioni. Anche operatori come Econduce, con 720 mila dollari raccolti, contribuiscono alla crescita dell’ecosistema.
Islanda, che grazie alla geotermia e alla stabilità di rete è diventata un laboratorio naturale per biotech e foodtech low-carbon. ORF Genetics ha chiuso un round da 5 milioni di euro nel 2025; Algalif ha avviato un’espansione da 30 milioni di dollari.
Norvegia, che ha trasformato competenze offshore in un polo globale di robotica marina e acquacoltura tech. Bluegrove ha chiuso 12 milioni di euro; Maritime Robotics ha raccolto 12 milioni di dollari; Aqua Robotics circa 11,9 milioni.
Questi casi mostrano che i round avanzati si spostano dove esiste un ecosistema territoriale capace di assorbire, integrare e scalare tecnologia. È esattamente il tipo di ecosistema di cui ha bisogno anche il Cleantech per reggere la pressione energetica dell’AI: territori in grado di trasformare innovazione in infrastruttura reale.
All’interno della stessa fotografia globale, c’è però un dato che riguarda da vicino l’Italia e che merita attenzione.

Nel Q3 2025, fra i most notable deals nella fascia pre-seed/seed, compare Tulum Energy, startup dell’idrogeno turchese basata su pirolisi del metano, che chiude un round seed da 27 milioni di dollari: il più grande round seed del trimestre a livello globale, in un cluster dominato da startup statunitensi.
Tulum produce idrogeno pulito trasformando il metano senza generare CO₂: invece di bruciarlo, lo “separa” in idrogeno e carbonio solido tramite calore elettrico. Un processo semplice da capire: si evita la combustione e quindi si evitano le emissioni.
Non è un caso isolato né un’eccezione statistica: è l’esito naturale della stessa logica di scala che osserviamo nei territori più avanzati.
Tulum Energy nasce infatti come spin-out industriale: un progetto costruito da TechEnergy Ventures, il corporate venture capital del gruppo Techint, a partire da un’idea sviluppata con il contributo tecnico di Tenova. A guidarlo c’è un team fondatore esperto — Massimiliano Pieri (CEO) e Donald Kendrick (CTO) — che opera sin dall’inizio dentro un contesto industriale reale, non in un perimetro accademico o puramente tecnologico.
Il round — guidato dal Green Transition Fund di CDP Venture Capital, affiancato da TDK Ventures, TechEnergy Ventures, MITO Tech Ventures e Doral Energy Tech Ventures — è una configurazione ancora rara in Italia: finanza pubblica che de-riska, capitale privato e VC deeptech che accelerano, corporate industriali che costruiscono capacità produttiva e un gruppo globale che accompagna la tecnologia fino al suo primo impianto.
Il ruolo di Techint è decisivo. Il gruppo — nato in Italia e oggi leader mondiale nell’acciaio, nell’energia e nelle infrastrutture — non si limita a investire: ha contribuito a costruire Tulum come progetto industriale, l’ha integrata nella propria strategia di decarbonizzazione e l’ha portata direttamente dentro un contesto operativo, nel sito di Pesquería, in Messico, dove sorgerà il primo impianto pilota.
È lì, nel cuore di una filiera siderurgica attiva, che una tecnologia hard-to-abate smette di essere una promessa e diventa capacità industriale: perché incontra domanda reale, processi esistenti, vincoli concreti e l’opportunità di testare la scalabilità sul campo.
Tulum mantiene anche un hub di R&D e ingegneria in Italia, segnale che il valore nasce dove esistono competenze e ricerca, ma cresce dove i territori sono in grado di trasformare l’innovazione in industria.
Per l’Italia, questo caso è più di una buona notizia: è una dimostrazione pratica che quando pubblico, privato e corporate agiscono come un ecosistema unico, possono emergere startup in grado di competere su scala globale. Ed è anche un promemoria: se vogliamo che il Cleantech regga la curva energetica dell’AI, abbiamo bisogno di molti più casi “Tulum” distribuiti nei territori.
Questi esempi, dai casi internazionali a quello di Tulum, mostrano una cosa molto semplice: la tecnologia può anche nascere ovunque, ma scala solo nei territori che sanno trasformarla in industria.
Ed è proprio qui che, guardando più da vicino l’esperienza delle startup cleantech europee, emerge il punto critico. Tra il momento in cui una tecnologia funziona e quello in cui trova un primo impianto reale si apre lo spazio più delicato di tutto il percorso. È lì che molte soluzioni si fermano, non per mancanza di innovazione, ma perché mancano domanda certa, infrastrutture, capitali allineati e condizioni industriali. È questo passaggio stretto che la letteratura chiama Valley of Death.
La tesi della Delft University of Technology (TU Delft) — “Valley of Death for European Cleantech Startups” (2023), sviluppata nella Faculty of Technology, Policy and Management — analizza con chiarezza perché molte tecnologie cleantech europee faticano a trasformarsi in capacità industriale.
La ricerca evidenzia che la Valley of Death non si colloca all’inizio del percorso, ma tra TRL 4–5 e TRL 8: la fase in cui una tecnologia funziona, ma deve ancora dimostrare domanda reale, bancabilità, contratti replicabili e affidabilità operativa dentro una filiera esistente.
Dalle interviste ai founder emergono pattern ricorrenti:
fino a TRL 5–6, grant e fondi pubblici sostengono prototipi e dimostratori;
è nel passaggio TRL 6–7 — quando servono il primo impianto in scala reale, i primi contratti pluriennali e l’integrazione in un sito industriale — che tutto si inceppa:
gli investitori equity vogliono ricavi ricorrenti che ancora non esistono,
le banche giudicano la tecnologia non bancabile,
le corporate esitano a impegnarsi in off-take di lungo periodo;
il risultato è una zona grigia fatta di piloti non scalabili, che non permettono di costruire una pipeline industriale credibile.
La tecnologia può anche nascere ovunque, ma scala solo nei territori che sanno trasformarla in industria.
Secondo la tesi, la variabile decisiva non è la maturità tecnica, ma la presenza di un ecosistema disposto ad assorbire la tecnologia: territori con domanda reale, filiere pronte, capitali coordinati, infrastrutture disponibili.
Non sorprende, quindi, che le tecnologie che superano la Valley of Death siano spesso quelle che — come nel caso citato in precedenza — trovano un’industria e un territorio pronti a sostenerle, piuttosto che quelle “più brillanti” sul piano tecnico.
È questo il punto essenziale: nel cleantech, il salto dal laboratorio all’industria non lo determina la tecnologia in sé, ma il contesto che la accoglie.
Ed è proprio in questo punto delicato — dove una tecnologia deve trovare un sistema capace di assorbirla — che torna in primo piano la dinamica con cui abbiamo aperto questo ragionamento: la crescita dell’AI. La corsa dell’intelligenza artificiale non è astratta né confinata al digitale: ha un peso fisico, energetico, industriale. Ogni modello più avanzato, ogni applicazione, ogni nuovo servizio genera una domanda crescente di elettricità, rete e capacità di bilanciamento. In altre parole: l’AI sta premendo esattamente sugli stessi nodi strutturali che il Cleantech deve risolvere.
I dati dell’International Energy Agency (IEA) mostrano una curva di domanda elettrica che accelera rapidamente, mentre il State of Climate Tech Q3 2025 evidenzia come il capitale sia diventato molto più selettivo: investe solo in soluzioni che offrono energia pulita, continua e tracciabile, cioè realmente “AI-ready”.
Senza un ecosistema di Cleantech AI-ready — nuova capacità pulita, sistemi di accumulo, demand response intelligente e reti in grado di gestire picchi di carico — la curva dell’AI si scontrerà presto con limiti fisici e regolatori, molto prima che con limiti computazionali.
Questa pressione crescente — tecnologie che chiedono sempre più energia e sistemi elettrici che non tengono il passo — rende evidente un punto cruciale: il Cleantech dovrebbe essere la risposta naturale alla curva dell’AI, ma oggi non scala con la velocità necessaria. Non per mancanza di innovazione, ma perché il passaggio dalla tecnologia all’industria è ancora frenato da nodi strutturali.
Ed è proprio qui che il State of Climate Tech Q3 2025 diventa utile: leggendo i flussi di capitale e i movimenti industriali globali, il report mostra che il Cleantech sta entrando in una fase di maturità in cui contano meno le promesse e molto di più la capacità di scalare davvero. Per questo sintetizza l’evoluzione del mercato in tre direttrici nette:
meno hype, più fundamentals
dal “moonshot” al “mass deployment”
preferenza per unit economics leggibili
Queste tre direttrici non sono solo un cambiamento di umore degli investitori: sono la conseguenza diretta dei blocchi strutturali che il Cleantech incontra quando passa dal prototipo all’industria.
E qui entra in gioco la tesi TU Delft, che completa il quadro: ciò che il report osserva “da lontano”, la ricerca olandese lo conferma da vicino, guardando la parte più difficile del percorso, quella tra TRL 4–5 e TRL 8.
Le interviste ai founder mostrano la stessa realtà che il report descrive su scala globale: tecnologie che funzionano, ma che senza un ecosistema pronto restano confinate a piloti; startup che ricorrono a grant anche in fasi avanzate per finanziare dimostratori; ricavi ponte che tamponano il vuoto di domanda industriale; deployment semi-commerciali usati per raccogliere dati reali; consorzi con corporate e utility necessari per accedere a infrastrutture e blended finance.
In altre parole, il State of Climate Tech Q3 2025 fotografa dall’alto ciò che la tesi TU Delft conferma sul campo: il Cleantech non rallenta per mancanza di idee, ma perché incontra barriere strutturali sempre negli stessi punti del percorso. E quando si sovrappongono la selettività del capitale descritta dal report e i colli di bottiglia individuati dalla ricerca olandese, la mappa diventa sorprendentemente chiara.
È da questa combinazione — macro e micro, mercato e operatività — che emergono i tre nodi che da anni limitano la scala del Cleantech e che oggi, più che mai, definiscono dove la tecnologia accelera e dove invece si ferma.
Queste evidenze rafforzano i tre nodi storici della scala cleantech:
Finanza che accompagna la scala
La barriera FOAK (First-of-a-Kind) è critica. Molte soluzioni sono tecnicamente mature, ma soffrono il primo impianto industriale. La tesi TU Delft mostra che le startup che superano questa fase costruiscono pacchetti finanziari ibridi (grant + debito + equity). Il report State of Climate Tech Q3 2025 conferma: il capitale privato torna dove il rischio è condiviso e dove esiste una pipeline industriale leggibile.
Mercati che creano domanda (CCfD)
I CCfD (Carbon Contracts for Difference) compensano il green premium per 10–15 anni. Sono strumenti che rendono bancabili investimenti industriali energivori. Il State of Climate Tech li identifica come segnali credibili di domanda, e la tesi TU Delft spiega perché: nella seconda metà della Valley of Death, quando la tecnologia è pronta ma il mercato non lo è ancora del tutto, la prevedibilità dei ricavi diventa la leva decisiva per sbloccare capitali e infrastrutture.
E quando questa prevedibilità si materializza — sotto forma di contratti, impegni industriali, percorsi di testing o contesti di deployment stabili — la scala diventa possibile. È il filo rosso che collega molti dei casi più interessanti oggi in circolazione.
In Germania, INERATEC, pioniera negli e-fuels, ha potuto realizzare il più grande impianto europeo grazie a un montaggio finanziario che offriva stabilità: la BEI che de-riska, Breakthrough Energy che accelera e partner industriali che assicurano una domanda credibile. Non è solo capitale: è capitale che si muove perché vede una traiettoria chiara.
Sempre in Germania, i CCfD per acciaio, cemento e chimica generano una prevedibilità ancora più esplicita: un prezzo garantito per 10–15 anni. Non è la tecnologia a cambiare, è il segnale di mercato che la rende bancabile.
Nel Regno Unito, l’ORE Catapult, sostenuto da UKRI, offre un’altra forma di prevedibilità: non dei ricavi, ma delle prestazioni, grazie a test in condizioni operative reali che riducono il rischio tecnico prima della fase commerciale. Anche qui la dinamica è identica: meno incertezza, più capitale disposto a entrare.
Infine, la stessa logica si ritrova nelle iniziative dual-use della NATO, con il programma DIANA e il NATO Innovation Fund (NIF). Investendo in microgrid resilienti, sistemi avanzati di stoccaggio e soluzioni per la continuità operativa delle supply chain, queste piattaforme creano contesti industriali e infrastrutturali in cui le tecnologie capital-intensive possono essere testate, integrate e scalate. La prevedibilità, in questo caso, nasce dal contesto: infrastrutture pronte, domanda certa, filiere già operative.
In tutti questi esempi, il meccanismo è lo stesso: quando attori pubblici o industriali introducono elementi di stabilità — un prezzo, un’infrastruttura, un percorso di testing o un commitment di domanda — il rischio percepito crolla e l’investimento diventa possibile.
Ed è proprio questa logica che ritorna se guardiamo ai segnali globali: Messico, Islanda e Norvegia mostrano che la scala emerge dove tecnologia e territorio si riconoscono. Questo apre domande cruciali:
quali territori italiani hanno la combinazione giusta di risorse, filiere e domanda reale?
quali verticali emergerebbero in un ecosistema coerente?
quali territori potrebbero attirare capitale globale?
La sfida, in definitiva, si gioca nei territori, non nei laboratori. È nei contesti urbani — dove energia, mobilità, acqua, edifici, reti digitali e dati convivono nello stesso perimetro — che la decarbonizzazione diventa davvero una capacità industriale e non solo una promessa tecnologica.
È dentro questa logica che si inserisce l’esperienza di ZERO, l’acceleratore cleantech della Rete Nazionale di CDP Venture Capital, in cui Zest ha co-investito insieme a CDP ed ELIS e che ha gestito dal 2021, con Eni come main partner e la partecipazione di Acea, CNR, Microsoft, SACE, Saipem, Vodafone e il supporto di ESA Φ-lab.
ZERO non è stato soltanto un acceleratore: è diventato un piccolo modello industriale, un luogo in cui startup, corporate, PMI e infrastrutture hanno iniziato a lavorare come una filiera unica. La sua forza è stata quella di portare le tecnologie dentro un ecosistema reale — non in un percorso astratto — e dimostrare che un’architettura industry-driven può allineare competenze, capitale e domanda, trasformando il Cleantech in capacità produttiva, non in un semplice catalogo di soluzioni promettenti.
Zest sta portando questa logica oltre ZERO, lavorando sull’Urban Tech come livello operativo del Cleantech e sull’AI come moltiplicatore di scalabilità. L’Urban Tech è il livello operativo di questa visione: dove reti, energia, edifici, acqua, rifiuti e mobilità si incontrano; dove l’AI può orchestrare consumi, accumuli e carichi; dove la decarbonizzazione diventa capacità territoriale.
Se Messico, Islanda e Norvegia insegnano qualcosa è questo:
il cleantech scala dove i territori diventano piattaforme industriali.
La sfida oggi non è inventare nuove tecnologie, ma distribuire rapidamente quelle esistenti.
Le città diventano nodi energetici intelligenti, i territori piattaforme industriali, il deployment una capacità.
La vera competizione del prossimo decennio non sarà tra tecnologie, ma tra territori.
L’Italia ha tutte le condizioni per costruire hub cleantech regionali capaci di attrarre capitali globali e generare impatto sistemico.
La sfida non è inventare: è distribuire, integrare, orchestrare.